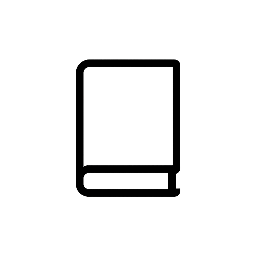Uscito postumo nel 1996 raccoglie una serie di scritti, racconti, recensioni, impressioni di questo scrittore errabondo, il cui filo conduttore è l’elogio del viaggio, dell’esplorazione, del nomadismo.
Uscito postumo nel 1996 raccoglie una serie di scritti, racconti, recensioni, impressioni di questo scrittore errabondo, il cui filo conduttore è l’elogio del viaggio, dell’esplorazione, del nomadismo.
Il solo leggere il titolo ha prodotto in me un’irrefrenabile voglia di muovere i piedi, proprio come John Belushi quando ha la visione della banda in “Blues Brothers”.
In queste pagine Chatwin stimola la nostra curiosità. In “andato a Timbuctù” ad esempio, ci invita a fare le valigie; il nome del luogo pronunciato in tanti modi diversi sembra aumentarne la distanza, amplificare il senso della lontananza che questo posto evoca. Nella descrizione del luogo sembra un quadro variopinto: il verde dell’acqua, l’azzurro del cielo,l’indaco delle vesti.
Il primo scritto “Ho sempre desiderato andare in Patagonia” ha il sapore di un manuale di formazione per scrittori. “Un posto per appendere il cappello” è scritto con la perizia dell’esperto d’arte, che Chatwin era. Ma in tutte le pagine è presente quell’istinto al nomadismo che trova la sua quintessenza nella rinuncia al possesso.
Ciò che però mi ha colpito di più è una frase nel primo autoritratto: nel descrivere se stesso bambino e la sua formazione culturale, maturata in un ambiente familiare particolarmente stimolante e profondamente dotto, egli ricorda come fu invitato ad appassionarsi al teatro inglese e conclude “vissuti come li ho da ragazzo, ora non riesco a vedere uno di quei drammi senza provare un senso di perdita”. Ebbene io amo pensare che si riferisse alla perdita di quel fervore, di quell’agitazione culturale che riempiva la sua vita familiare. Insomma una perdita esistenziale di uno stile di vita, improntato alla soddisfazione intellettuale, che sembra smarrito nel nostro quotidiano; unico bene, in questa rinuncia al possesso, che vale la pena di conservare.
Voi che ne pensate?