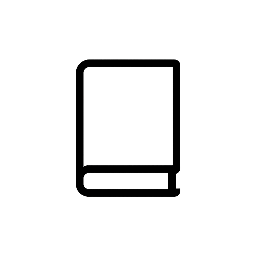Don Gaetano si rigirava nel letto, spesso per addormentarsi si disegnava in mente la pianta della casa sua o di quelle dei suoi figli, e questo in genere gli conciliavano il sonno. Ma quella notte si era fissato con il palazzo del delitto, disegnava l’androne, le scale in fondo, il locale sulla sinistra che lui aveva comprato e trasformato in garage, e sulla destra il basso della signora Palumbo, e lì c’era il problema perché era sicuro che, mentre il suo garage era lungo quanto l’androne ed il vano delle scale, il basso era più corto, ci doveva essere un altro vano ma per quanto si sforzasse non riusciva a ricordare, nella casa del delitto, nessuna altra porta, oltre quelle del bagno e della cucina che però erano sulla destra e non in fondo. Visto che proprio non riusciva a dormire, che avevano tolto i sigilli e che il cugino gli aveva affidato le chiavi, si rivestì silenziosamente, prese una torcia ed andò a controllare.
Con soddisfazione capì subito che aveva ragione, la stanza era sì larga ma troppo poco profonda. Si avvicinò al grosso armadio che occupava una buona parte della parete di fronte e lo aprì: era praticamente vuoto, provò a spostarlo, era abbastanza leggero così lo scostò completamente dalla parete e trovò la porta che cercava. Dava in un ripostiglio pieno di imbrogli ma al centro, ben in vista, c’era una botola chiusa da un catenaccio.
Ci mise un po’ di tempo a cercare le chiavi, ma quando aveva deciso ormai di scassinarlo, in un barattolo della cucina trovò la chiave giusta. Aprì facilmente la botola e cominciò a scendere i ripidi scalini.
Anche il commissario Dauria quella notte non riusciva a dormire, il disagio che era iniziato silenziosamente mentre la vecchia raccontava, era esploso in un dolore sordo nell’uscire in strada, gli odori della cena, che rendevano greve l’aria del vicolo, lo aveva quasi soffocato, un desiderio fisico dell’aria fredda e tersa del suo paese appena profumata, a quel ora, dall’odore della legna che ardeva nei caminetti, si era presto trasformato in nostalgia. Ed era con questa parola che la sua mente giocava mentre cercava di prendere sonno. La scomponeva: nostos – algos, nostos il ritorno a casa, algos il dolore: il dolore del ritorno a casa, la nostalgia della casa. Questa parola così evocativa non era degli antichi greci, era stata coniata solo nel tardo ‘700, come se per gli antichi il desiderio del ritorno non si trasformasse in dolore, come se ancora credessero possibile il ritorno, come se non avessero la consapevolezza che mai si ritorna nello stesso luogo che si è lasciato, eppure lo dovevano sapere, il panta rei era una loro scoperta…così, giocando pedantescamente con il suo greco scolastico il commissario alla fine si addormentò.
Ma qualcosa di quei pensieri notturni doveva essere rimasto perché mentre si preparava alla solita giornata di lavoro, un istinto incontrollabile gli disse che era impossibile andare in ufficio, telefonò dicendo che non andava perchè stava seguendo una pista, invece della moto prese la macchina e partì per il paese. Finché fu sull’anonima autostrada pensò a Marinella, la sua eterna fidanzata, la sua Penelope, come la chiamava quando voleva farla arrabbiare, l’avrebbe certamente trovata al lavoro, nell’azienda agricola che dirigeva con il padre, si immaginava la sua sorpresa, forse la sua ansia e poi la sua allegria per quel arrivo inatteso. Poi, lasciata l’autostrada, ritrovò il noto paesaggio, le dolci, verdi colline, i paesi ordinatamente disposti lungo la statale e finalmente il fiume luccicante, che scorreva puro e ignaro in fondo alla valle. Normalmente quando arrivava a quel punto del viaggio il commissario diventava allegro, a volte addirittura cominciava a fischiettare sottovoce, quel giorno invece fu di nuovo ripreso dal dolore della sera prima, le immagini familiari gli riportarono alla mente, con il racconto della vecchia, il pensiero che i vecchi hanno negli occhi immagini perse per sempre. Cominciò a chiedersi se le immagini di quel paesaggio che ritrovava sempre uguale fossero le stesse che suo nonno si era portato via per sempre. Pensò a suo nonno che non aveva mai conosciuto perché era scomparso in guerra: l’otto settembre lo aveva sorpreso al nord, aveva sciolto il suo battaglione e di lui non si era saputo più nulla. Da ragazzo il commissario aveva cercato di sapere se era morto per caso, senza schierarsi o se invece avendo scelto era morto combattendo e da quale parte. Un’ estate di tanti anni prima aveva tormentato con le sue domande un pastore che aveva fatto la guerra con suo nonno e ora ritrovava nella sua reticenza le parole della signora Carmela, anche il suo ex soldato non voleva raccontare, diceva di non sapere, di non ricordare, tanto da fargli sospettare una inconfessabile verità. “Te lo giuro sulla testa dei miei figli, sull’anima dei miei morti, non lo so, tuo nonno non era un tipo facile, certo non diceva a noi soldati cosa pensava, è anche vero che non era proprio fissato come altri con quelle cose là del fascismo, se ti scordavi ti rimproverava ma non ne faceva una tragedia ma questo non vuol dire, era più la gente del popolo a tenerci, i signori sotto sotto ci sorridevano, quindi non lo so cosa ha fatto tuo nonno dopo che ci mandò tutti a casa, certo non ci consegnò ai tedeschi, ma perché lo fece non lo so. Ma perché vuoi sapere, che cambia per te se è saltato su una mina tornando giù, se sta in una fossa comune ucciso dai comunisti, o se invece è salito in montagna ed è caduto combattendo con loro … che te ne importa, che conta oggi tutto questo?”
Così gli parlava il pastore ed ora lo capiva, anche se era bello pensare ad un nonno eroe divenuto terra e rovi nel fondo di un crepaccio alpino, quello che contava per lui era stata la sua assenza. Quando avrebbe avuto bisogno di lui, alla morte dei suoi genitori in un incidente d’auto, per quelle stesse curve che ora lui stava percorrendo, magari guardando proprio quel nocelleto che gli stava scorrendo di lato, il nonno non c’era e la nonna era morta di dolore e lui, povero infante di neanche dieci mesi era rimasto completamente solo. Ecco quello che contava: che tutte quelle morti gli avevano sottratto l’infanzia. Era stato messo all’ orfanotrofio del paese vicino e lì era rimasto per nove anni finché una sorella del padre, rientrata dall’America, gli aveva dato una famiglia ed una adolescenza.
Intanto era arrivato al fiume, ora doveva attraversare il ponte e percorrere l’ultima salita verso il suo paese, invece prese la strada che costeggiando il fiume portava ad un altro paese, quello dell’orfanotrofio. Si fermò nella piazza centrale, lasciò la macchina, entrò nel bar che aveva ancora la tenda di fili metallici, ordinò un caffè e si sedette fuori al tavolino, questo irrimediabilmente di plastica. Aveva davanti, in pieno sole, la facciata del convento, sulla destra le file ordinate delle finestre cedevano il posto al portale della chiesa. Era tutto deserto, immobile e silenzioso. La sera prima la vecchia aveva detto della maestra che era severa ma giusta, anche lui aveva pensato questo delle suore che lo avevano cresciuto, una sensazione di freddo, come nel racconto di Joyce dei suoi anni in collegio e improvvisamente si accorse che la vecchia aveva raccontato un episodio che anche Joyce racconta: quello della mano che viene distesa per essere meglio percossa. Lui, pur senza averla vissuta, la sentiva sua quella scena, ed era strano che tre persone così lontane condividessero la stessa emozione. Non sapeva perché era andato lì, cosa si aspettava da quel pellegrinaggio ma questo era lo spazio della memoria più antico che aveva, quello più vicino ai suoi genitori. Di suo padre, di sua madre aveva solo delle foto in bianco e nero, da ragazzo le aveva fissate a lungo sperando di ritrovare un sentimento, una sensazione almeno, ed aveva odiato quel neonato che sentiva l’abbraccio della madre e lo sguardo del padre chino sui due e aveva tenuto tutto per se, lasciando a lui solo un disperato buco nero. Finì di bere il caffè, tornò dentro per pagare e poi con calma ritornò alla macchina e mentre si metteva al volante altre domande arrivarono inattese: cosa avrebbe fatto se avesse potuto incontrare la persona che, sbucando a tutta velocità da una curva, lo aveva privato dei genitori e dell’infanzia? Quanto intenso sarebbero stati il dolore e l’odio? Potevano diventare desiderio di vendetta? Come unguento sulle ferite, il pensiero della zia venne, come da piccolo, ad addolcire la sofferenza. Passo a salutarla, si disse e invece della strada della fattoria deviò verso il paese. La zia aveva raggiunto a Boston il suo bel soldato yankee, che in realtà era figlio di compaesani emigrati, ma dopo quasi venti anni di vita americana e tre figli si era ammalata di nostalgia ed il marito, per non vedersela morire, aveva riportato tutti al paese. Per prima cosa, in una mattina di sole, erano venuti al convento e incuranti della sua diffidenza, lo avevano avvolto con il calore di una famiglia. Da allora era diventato il figlio minore, il fratello più piccolo per i suoi cugini e gli anni da orfano erano diventati un tratto del carattere, una certa predisposizione alla malinconia. Gli zii gli avevano regalato una adolescenza spensierata tanto che frequentare il ginnasio dai Gesuiti nel capoluogo non era stato un problema, era andato in collegio con gli altri ragazzi del paese, compagni di scuola e di pomeriggi estivi. Poi c’era stata l’università a Roma, il lavoro, e una Pasqua di qualche anno prima, uscendo con tutta la famiglia dalla messa, non aveva riconosciuto la selvaggia ragazzina dalle grosse trecce nere, suo incoffessato amore, nella splendida personificazione della dea Terra che, al braccio del padre, sul sagrato, salutava la zia. Come in un film anni cinquanta, erano stati presentati e da allora erano eternamente fidanzati.
Ma se la zia non fosse tornata, se tutta la sua giovinezza si fosse svolta in orfanotrofio, se non avesse studiato, se non avesse trovato lavoro, se non avesse nessuno da amare, incontrando la causa di questo deserto avrebbe forse potuto uccidere? il male di un ritorno impossibile avrebbe potuto portarlo al delitto?
(5. continua)